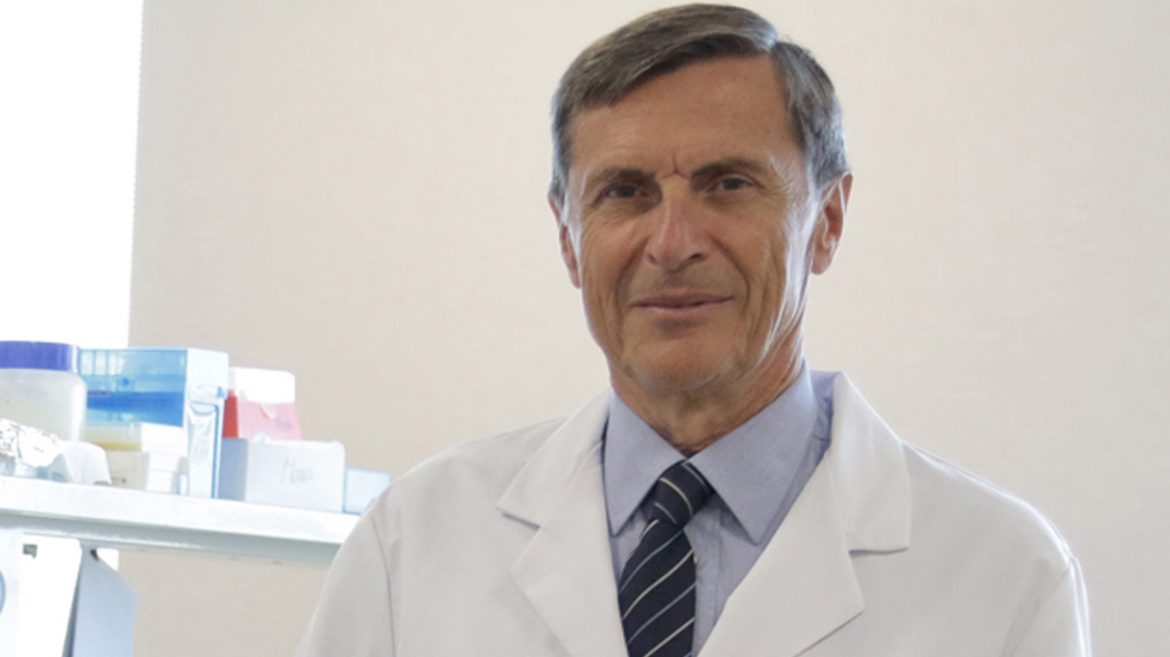Alberto Mantovani è il primo italiano che lavora in Italia a vincere il prestigioso premio internazionale che la Fondazione Pezcoller e l’American Association for Cancer Research (AACR) attribuiscono a chi ha raggiunto straordinari successi nella ricerca sul cancro.
L’annuncio ufficiale è stato dato lo scorso 31 marzo 2018 ad Atlanta, durante il convegno annuale dell’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR, appunto), in una sala gremita da migliaia di oncologi provenienti da tutto il mondo, davanti ai quali Mantovani, il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale, ha tenuto il suo discorso.
La consegna formale del premio è avvenuta l’11 maggio al Teatro Sociale di Trento, dove ha sede la Fondazione Pezcoller, istituita nel 1980 con il fine istituzionale di promuovere la ricerca oncologica.
Le motivazioni: per le sue ricerche su cancro e sistema immunitario
«Alberto Mantovani è un autorevole medico e scienziato che da decenni è leader nel campo dell’immunologia dei tumori – ha sottolineato durante la cerimonia americana Margaret Foti, amministratore delegato dell’AACR -. Le sue ricerche pionieristiche hanno dimostrato che i macrofagi possono favorire lo sviluppo di una lesione cancerosa nel micro-ambiente tumorale, instaurando una relazione tra l’infiammazione dell’organismo e la formazione del cancro. E questa scoperta è alla base di innovative opportunità terapeutiche, perché hanno fornito nuovi “bersagli” da colpire con farmaci appositamente creati per spegnere quell’infiammazione che nutre le cellule cancerose». Le sue ricerche pionieristiche hanno infatti indagato sulla «relazione pericolosa» fra infiammazione, malfunzionamento del sistema immunitario e insorgenza di un tumore, contribuendo in modo determinante a porre le basi di quell’immunoterapia che oggi è diventata la quarta grande strategia contro il cancro, accanto a chirurgia, chemioterapia e radioterapia.
Un sogno che ha attraversato 100 anni di storia della medicina
Un passo avanti tanto determinante da far guadagnare il Nobel per la Medicina 2018 all’immunologo Usa James P. Allison e al giapponese Tasuku Honjo. C’è voluto però oltre un quarto di secolo perché i lavori degli scienziati in laboratorio venissero tradotti in medicinali utilizzati in una corsi d’ospedale. E’ difficile da spiegare a chi è malato oggi, ai suoi familiari, che vorrebbero vedere subito i risultati. Ed è spesso frustrante anche per i ricercatori, che trascorrono intere giornate fra esperimenti e studio. Ma è la realtà: le conquiste in ambito medico e scientifico richiedono anni. E molta pazienza.
«Negli ultimi anni, grazie all’immunoterapia, ho avuto la fortuna di veder realizzare un sogno che ha radici antiche – dice Mantovani -: i padri della medicina scientifica speravano di poter sconfiggere tutte le malattie con il contributo dell’immunologia. Mancavano le tecnologie, non erano ancora state raggiunte le conoscenze necessarie, ma dopo quasi 100 anni di frustrazioni e scetticismo ora abbiamo i primi farmaci in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario a lottare contro diversi tipi di cancro. Stiamo imparando a capire come scardinare la resistenza delle cellule cancerose alle cure, risvegliando le naturali difese del nostro organismo e “insegnando” loro come reagire contro la malattia».
I tempi lunghi della ricerca sono difficili da comprendere per chi ha un tumore oggi o soffre per una persona cara malata. Come accettare questa verità, in una società che è fortemente improntata sulla rapidità in tutti i settori?
«Capisco benissimo le difficoltà di malati e familiari che cercano oggi una cura per la loro malattia, ma la ricerca scientifica ha dei tempi lunghi anche, soprattutto, in difesa dei pazienti – sottolinea Mantovani -. Il Nobel assegnato nel 2018 è collegato a una scoperta fatta negli anni ’80. Poi, negli anni ’90, si è compreso (su topi, modello pre-clinico) che c’era qualcosa che frenava il sistema immunitario e nel 2011 si sono visti i risultati, nei pazienti con un melanoma cutaneo, delle prime terapie che andavano a rimuovere quel freno. Ed erano risultati ottenuti in malati tenuti sotto osservazione già per diversi anni, perché serve cautela. Non si può gridare al “miracolo”. Tutto ciò che da molte speranze e molto in fretta, senza le dovute verifiche, dovrebbe insospettire»
Come mai ha deciso di puntare proprio sull’immunoterapia?
«Mi sono innamorato dell’immunologia e fra qualche anno festeggerò le nozze d’oro con questa mia passione per il sistema immunitario, che mi ha affascinato anche perché era un filone di studi trasversale a patologia diverse – risponde lo scienziato -. Il malfunzionamento delle nostre difese è infatti alla base di malattie differenti, non solo del cancro. Sono rimasto affascinato da quelli che ho definito i “poliziotti corrotti” (ovvero i macrofagi, globuli bianchi che provocano una reazione infiammatoria per distruggere batteri, virus e funghi) perché anziché combattere, facilitano la crescita e lo sviluppo del cancro. Era il 1978 quando ho osservato per la prima volta il ruolo dei macrofagi al microscopio e ricordo di aver sognato che un giorno saremmo riusciti a fermare questo processo, a far funzionare correttamente il nostro sistema immunitario e che avremmo avuto un successo concreto sui pazienti. Molti non ci credevano. Chi ha fatto immunologia negli anni Novanta e a inizio Millennio ha avuto il grande merito di aver continuato a crederci (e un grazie va anche a chi ha sostenuto i finanziamenti in questo settore), quando nessuno se ne interessava più».
Ha mai pensato di aver sbagliato tutto e di dover cambiare strada?
«No. Per alcuni tratti ho nuotato controcorrente, però i dati delle ricerche indicavano che c’erano buone ragioni per andare avanti. E le prime conferme sono arrivate quando abbiamo pubblicato due importanti studi su una rivista di rilievo come Lancet, nel 2001 e nel 2008: significava che il paradigma aveva convinto la comunità scientifica».
Oggi ha 70 anni, numerosi e prestigiosi riconoscimenti in bacheca, come vede il futuro della lotta al cancro? Ce la faremo?
«Come in amore, in un matrimonio che funziona, più si va avanti e più ci si conosce. Più comprendo l’immunologia e più sono innamorato e stupefatto e, nelle mie ricerche, si aprono nuove finestre e scenari. Ormai è chiaro che con la parola cancro si intendono centinaia di malattie diverse, non c’è un’unica soluzione. E’ una sfida aperta e grande. Umberto Veronesi, Gianni Bonadonna ce lo hanno insegnato: si procede un passo dopo l’altro. Si va avanti come in montagna, per me che sono un alpinista: si scala un tratto alla volta, si avanza in fila, si fa avanzare un compagno, e solo così si conquista la vetta. Quello che però è importante è non pensare soltanto alle nuove terapie. Molto, moltissimo, può essere già fatto con la prevenzione: non fumare, non essere sovrappeso, sfruttare i vaccini che già esistono e funzionano. Servono più finanziamenti e attività di ricerca in questo settore».
Che suggerimento darebbe ai giovani ricercatori di oggi?
«L’ottimismo è un dovere morale. Il mio pensiero è racchiuso nel libro che ho pubblicato su idea di Elisabetta Sgarbi, Non aver paura di sognare. Decalogo per aspiranti scienziati (2016, La nave di Teseo). Il mio messaggio, in estrema sintesi, è già nel titolo: non bisogna temere di guardare avanti e di pensare in grande, credendo fino alla fine a quello che i dati nei laboratori ci dimostrano. Certo, io sono un grande privilegiato, ho avuto fortuna. Usare le armi immunitarie contro il cancro è un’idea che ha attraversato 100 anni di storia della medicina, con tanti periodi di bassa e fallimenti, ma io ho avuto il privilegio di vedere l’inizio di questo grande sogno che si avvera».
*Corriere della Sera, 10 maggio 2019