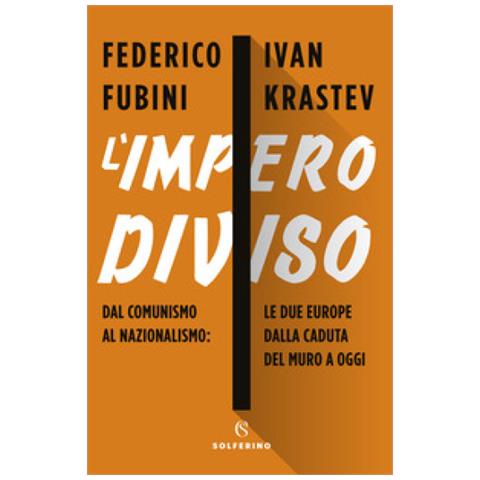Per l’ultima volta trent’anni fa l’Europa fu teatro di eventi che il resto del mondo non poté fare a meno di seguire con entusiasmo. Chiunque all’epoca fosse almeno un bambino ne ha un ricordo diverso, eppure quasi sempre con un punto in comune: in Occidente la memoria di quegli eventi è organizzata per immagini. Non esperienze personali, ma filmati: statue di Lenin che cadono o gente che si arrampica sopra il Muro di Berlino.
Il crollo del comunismo fu il trionfo dell’aspirazione alla libertà di milioni di europei, ma per chi viveva nella parte occidentale del continente rappresentò anche l’apoteosi di qualche breve sequenza televisiva come sintesi della storia. L’effetto su centinaia di milioni di occidentali fu così potente che da allora si è continuato a cercare di riviverlo. Quando nel 2003 gli iracheni tirarono giù la statua di Saddam Hussein a Bagdad, sospinti dall’esercito americano, il rito apparve subito un po’ posticcio. Ma in fondo discendeva dall’estetica del 1989. Una generazione di europei è cresciuta sapendo benissimo quale fosse il messaggio di quelle statue che continuavano a cadere: la storia ha una direzione — la nostra — perché gli esseri umani aspirano a essere liberi e a far sentire la propria voce. Tale convinzione ha poi un corollario che riguarda le condizioni materiali di vita: le stesse persone che vogliono essere libere sono anche guidate dall’intenzione di migliorare il proprio status e sono capacissime di agire, se viene dato loro uno spiraglio, per realizzare queste aspirazioni. Siamo animali razionali: comprendiamo il nostro interesse, e perseguirlo ci viene naturale. Questo dicevano quelle statue precipitando in mezzo alla polvere. Per lo meno, questo è ciò che noi udivamo nel frastuono della caduta.
Da allora si fatica a ripescare nella memoria immagini altrettanto esaltanti, ma meno vecchie. Le rivolte arabe hanno portato una guerra interminabile in Siria e una dittatura militare in Egitto. Le rivoluzioni colorate in Ucraina o in Georgia hanno portato l’ingerenza militare della Russia. Nel frattempo Freedom House ha stimato che nel 2018 per il tredicesimo anno la democrazia rappresentativa era in ritirata nel mondo. In Ungheria un unico partito controlla le istituzioni e la vita civile, in Polonia il potere politico ha invaso lo spazio giudiziario. Eppure i governi in questione sono rimasti popolari fra i cittadini, e l’Unione Europea li ha lasciati sostanzialmente indisturbati. Non ha cercato di affermare i principi per i quali trent’anni fa tutti ci eravamo incollati ai televisori.
Del resto, quando immagini simili a quelle di trent’anni fa arrivano ai giorni nostri, presentano differenze che potrebbero farci riflettere. A Hong Kong nell’estate del 2019 un gruppo di manifestanti abbatte una struttura di metallo e cerca di darle fuoco. Il video che mostra la demolizione nei primi otto giorni è stato visto quattordici milioni di volte sulle reti sociali. Anche lì la folla è sovreccitata ma l’oggetto su cui infierisce non è un’immagine, è un palo: sosteneva alla sommità una telecamera cinese per il riconoscimento facciale. A essere abbattuta non è più l’effigie di un’idea, i dimostranti si accaniscono su un sistema di intelligenza artificiale che registra e analizza i tratti del volto dei passanti. È una tecnologia simile a quella applicata in milioni di angoli di strada — con una finalità diversa — in sistemi democratici nei quali le persone ritengono di essere perfettamente libere.
Proprio trent’anni fa Hyman Minsky ebbe qualcosa da dire in proposito. Minsky era un economista americano, figlio di esuli menscevichi bielorussi, la cui adolescenza era coincisa con la Grande Depressione. Negli studi si convinse che le persone possano abituarsi talmente tanto a condizioni di vita favorevoli, che iniziano ad agire con noncuranza. Minsky parlava di ciò che lo interessava di più, i mercati finanziari e le loro crisi. Pensava che quando le fasi di stabilità proseguono molto a lungo, gli investitori perdono memoria dei momenti avversi e li percepiscono come un’ipotesi irreale. Si indebitano, si sobbarcano di sempre maggiori rischi, sono ormai del tutto impreparati a un cambiamento del clima. Entrano nelle crisi perché ne hanno perso la memoria.
Per più di vent’anni dopo la morte di Minsky questa teoria non venne presa molto sul serio, ma poi nel 2008 il mondo si ricordò di lui. Ma immaginiamo un momento che questo figlio di profughi appartenenti a una minoranza etnica politicamente sconfitta alla periferia di un impero in declino non stesse parlando di finanza. Immaginiamo che stesse parlando di democrazia e di libertà. Può esistere un «momento Minsky» della libertà nel quale gli uomini la perdono, perché perdono la memoria del suo opposto?
Questa domanda comporta chiedersi su che gradino i cittadini di un Paese mettano la libertà nella classifica dei loro desideri in confronto ad altri beni: la sicurezza dei confini, l’identità, l’efficienza della giustizia e dello Stato, il senso di ordine e prevedibilità del futuro, il potere d’acquisto. La crisi finanziaria ha dimostrato che la saggezza collettiva degli esseri umani a volte può rivelarsi tutt’altro che tale: l’abitudine al benessere è in grado di sopprimere la percezione del rischio, portando accecamenti e catastrofi. Qualcosa del genere può accadere anche nella relazione psicologica fra i cittadini e la loro libertà collettiva?
Una recente ricerca del Pew Research Center mostra per esempio che nel 2018 il 54% degli italiani riteneva pericoloso andare in giro di sera. La loro percezione di insicurezza fisica è più acuta che in tutti i ventisette Paesi nei quali Pew ha condotto il sondaggio, salvo Grecia, Tunisia, Nigeria e Argentina. Eppure, negli indici internazionali sull’incidenza dei delitti, l’Italia risulta meno pericolosa di Stati Uniti, Svezia, Francia, Kenya o Brasile, dove i cittadini si sentono più sicuri che in Italia.
Sempre in Italia, solo una minoranza (43%) considera protetto il diritto delle persone a esprimere la propria opinione. E tra i ventisette Paesi nei quali Pew ha rivolto la domanda, solo in Brasile la cittadinanza risulta più scettica riguardo alla propria libertà di parola. Persino in Russia, in Ungheria o nelle Filippine le maggioranze avvertono una maggiore libertà di esprimersi e, ancora una volta, le risposte degli italiani non corrispondono alla realtà: Reporter senza frontiere colloca l’Italia persino sopra gli Stati Uniti per la libertà di stampa.
Noi italiani viviamo in democrazia, ma ci sembra di aver già perso le libertà dall’aggressione fisica o da quella nei confronti delle nostre idee. Allo stesso modo, gli italiani per lo più ritengono di non avere opportunità di migliorare il proprio tenore di vita; pensano che la giustizia non sia uguale per tutti; reputano i politici corrotti e indifferenti; ritengono che non possa cambiare granché anche se cambiano i partiti al potere. In altri termini, molte persone in Italia non sembrano più dare importanza al sistema democratico perché pensano che di esso non resti che l’apparenza. I suoi obiettivi a tanti paiono essere già stati traditi. A trent’anni dalla caduta delle statue, da questa parte del Muro parecchio resta da ricostruire e il tempo stringe, prima che arrivi qualcuno a offrire soluzioni diverse.